Tra le pieghe del paesaggio salentino, luogo di tradizioni millenarie e fede popolare, le edicole votive rappresentano un patrimonio culturale e spirituale di grande valore. Questi piccoli altarini, disseminati nei centri storici dei paesi e sparsi tra gli uliveti della campagna, raccontano storie antiche, leggende e pratiche di devozione che intrecciano sacro e quotidiano, architettura vernacolare e immaginario collettivo.
 Le Origini e il Significato delle Edicole Votive
Le Origini e il Significato delle Edicole Votive
Il termine aedicula, nell’antica Roma, indicava un piccolo tempietto o santuario, riduzione in miniatura dei grandi templi dedicati agli dei. Nel Salento, questa tradizione si è trasformata nelle edicole votive: piccoli spazi sacri costruiti all’aperto, spesso incastonati nei muri di case o lungo le strade di campagna, destinati ad ospitare immagini sacre di santi, Madonne o simboli religiosi.
Nate dalla volontà di esprimere fede e gratitudine, ma anche di chiedere protezione e sicurezza, le edicole hanno avuto nel tempo un ruolo centrale nella vita spirituale e sociale delle comunità salentine.
Edicole di Paese e di Campagna: Funzioni e Differenze
Nel tessuto urbano dei paesi salentini, le edicole votive sono spesso collocate in angoli di strade, piazzette o davanti a chiese e palazzi antichi. Qui, diventano luoghi di preghiera quotidiana e di incontro tra vicini, custodi di una religiosità popolare semplice e sentita. La loro funzione è anche quella di marcare luoghi importanti o tragitti devozionali.
In campagna, invece, le edicole avevano spesso una doppia valenza: religiosa e pratica. Erano punti di riferimento per i contadini e i viandanti, simboli di protezione contro le intemperie, le malattie o i pericoli del lavoro nei campi. Spesso situate lungo sentieri o strade secondarie, servivano anche come segnaletica sacra e custodi di leggende legate alla terra e ai suoi ritmi.
Le “Cunneddhe”: piccole architetture identitarie
Nel Basso Salento, in particolare nelle campagne tra Presicce, Acquarica e Specchia, le edicole votive assumono spesso la forma delle cosiddette cunneddhe. Si tratta di piccole costruzioni a pianta quadrata o rettangolare, con volta a botte o a cupola, interamente in pietra a secco o intonacate, che ospitano immagini sacre e icone mariane.
quadrata o rettangolare, con volta a botte o a cupola, interamente in pietra a secco o intonacate, che ospitano immagini sacre e icone mariane.
Il termine cunneddha deriva dal latino connetta (piccola stanza) e indica proprio un piccolo ambiente coperto, adibito a culto o a sosta del viandante. Queste strutture, spesso mimetizzate tra gli ulivi, fungono da veri e propri templi rurali, carichi di spiritualità e di memoria collettiva.
Un esempio suggestivo si trova nelle campagne di Patù, lungo la strada per Marina di San Gregorio: una piccola edicola in conci squadrati, custodisce un affresco ormai sbiadito della Madonna del Passo, venerata come protettrice dei viaggiatori.
Storie, Leggende e Miracoli
Le edicole votive sono legate a numerose storie popolari e miracoli raccontati di generazione in generazione. Si narra di grazie ricevute, guarigioni improvvise, apparizioni e protezioni durante eventi calamitosi. In molte comunità, esse diventavano tappe obbligate durante le feste patronali o le processioni, alimentando un rapporto intimo e collettivo con il sacro.
A Galatone, per esempio, la celebre edicola dedicata al Santissimo Crocifisso della Pietà, scolpita nella pietra, ha dato origine alla grande devozione che ogni anno richiama fedeli da tutto il Salento. A Specchia, l’edicola votiva con la Madonna del Rosario sulla facciata di Palazzo Risolo è ancora oggetto di offerte votive nei giorni di festa.
 L’Importanza Architettonica e Artistica
L’Importanza Architettonica e Artistica
Sebbene spesso di dimensioni modeste, le edicole votive sono preziosi esempi di architettura vernacolare. Caratterizzate da forme semplici ma eleganti, con archi, timpani e nicchie, sono decorate con affreschi, pitture, statue o maioliche. Spesso riflettono lo stile e le influenze delle epoche e delle aree in cui sono state realizzate, rappresentando un continuum tra arte popolare e architettura sacra.
Il Progetto VIVART a Parabita: Rinnovare la Tradizione con l’Arte Contemporanea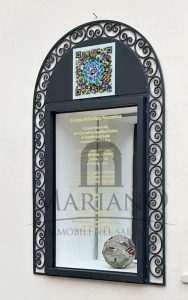
A Parabita, piccolo borgo nel cuore del Salento, le edicole votive stanno vivendo una nuova primavera grazie al progetto VIVART – un’iniziativa che coinvolge sedici artisti contemporanei italiani e internazionali chiamati a reinterpretare questi piccoli santuari popolari attraverso opere site-specific.
 Le edicole, alcune in stato di abbandono, altre costruite ex novo seguendo i canoni tradizionali, sono diventate contenitori di sculture, installazioni e opere pittoriche che dialogano con il luogo e la sua storia. Artisti come Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Luigi Presicce e molti altri hanno trasformato il centro storico e anche le zone rurali di Parabita in un percorso d’arte diffusa che coniuga spiritualità antica e linguaggi contemporanei.
Le edicole, alcune in stato di abbandono, altre costruite ex novo seguendo i canoni tradizionali, sono diventate contenitori di sculture, installazioni e opere pittoriche che dialogano con il luogo e la sua storia. Artisti come Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Luigi Presicce e molti altri hanno trasformato il centro storico e anche le zone rurali di Parabita in un percorso d’arte diffusa che coniuga spiritualità antica e linguaggi contemporanei.
Il sindaco Stefano Prete sottolinea come VIVART rappresenti un ponte tra passato e futuro, capace di riattivare lo spazio pubblico, stimolare la condivisione e valorizzare il patrimonio nascosto del borgo, rendendolo una vera e propria “Città per il Contemporaneo”.
Conclusioni
Le edicole votive del Salento sono molto più di semplici piccoli altari: sono custodi di memoria, simboli di identità culturale e architettonica, nonché luoghi vivi di fede e incontro. Attraverso iniziative come VIVART, questo patrimonio prezioso continua a evolversi, rinnovandosi e arricchendosi grazie alla contaminazione con l’arte contemporanea, garantendo così la sopravvivenza di una tradizione che parla al cuore della comunità salentina e a tutti coloro che visitano questa terra.



